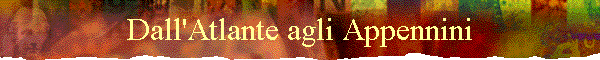“La testa di Youssef ciondola sulla spalla di Sidi Habibi seguendo
l’oscillazione sempre più forte del peschereccio; il rullio si confonde
con quello del camion che un mese prima dall’aeroporto di Tunisi lo ha
portato a Tripoli: un continuo dondolio di teste e gambe tra improvvisi
sobbalzi nella strada accidentata. Un sonno a brandelli…”.
Non deve essere stato tanto facile per il piccolo Youssef intraprendere un
viaggio molto pericoloso e difficile per la sua età. Youssef non fa certo
parte di quel mondo cellofanato delle merendine o delle scarpette griffate
cui si sofferma spesso la comunicazione per l’infanzia. Fa parte di un
altro universo, quello di chi si deve guadagnare la vita con fatica e
dolore e, quotidianamente, prova sulla propria pelle la carezza del freddo
pungente, il selciato sotto la schiena, l’umidità, l’incertezza che piova
da un momento all’altro, la paura di svegliarsi derubato. Quello di
Youssef è quasi un mondo a parte, quello degli immigrati, che ruota
attorno a quelle persone molto spesso emarginate da una società ricca di
valori vuoti nella loro intima essenza. Un mondo che per raggiungerlo e
toccare con mano è necessario attraversare il “mare aperto” di un “blu
senza scampo” “che a poco a poco si fa nero”. Un mare notturno dove
l’orizzonte è dipinto nel cuore di Youssef, giovane marocchino alla
ricerca della propria mamma di cui da troppo tempo non ha notizie. Di qui
la ferma decisione di intraprendere il viaggio verso quell’isola
sconosciuta chiamata Sicilia. E’ attorno a Youssef che ruota l’intero
intreccio narrativo proposto dalla scrittrice calatina Maria Attanasio
nella sua recente fatica letteraria dal titolo “Dall’Atlante agli
Appennini” (Orecchio Acerbo Ediz., 2008, pp. 112).
Si tratta di un racconto bello, coraggioso, gravido di tante domande che
portano, inevitabilmente, a tante riflessioni, ma anche un’occasione di
rilettura e rivisitazione, in chiave moderna, di alcune delle pagine più
amare di De Amicis – a cento anni dalla sua scomparsa – “Dagli Appennini
alle Ande”, uno dei più celebri “racconti mensili” incastonati nel volume
che ha rappresentato il “diario scolastico” di una nazione, il libro
“Cuore”. Nella scrittura dell’Autrice si rileva l’impegno civile, la
cocente rabbia davanti all’ingiustizia, ma soprattutto emerge dirompente
la capacità di descrivere, raccontare, di rendere tangibile, il problema
epocale delle migrazioni, i drammi che ne scaturiscono, lo strappo
violento dalla propria cultura, famiglie smembrate, spesso alla deriva,
alla ricerca di una terra lontana dal suolo natio.
Ma se titolo, trama, personaggi,
presentano un richiamo esplicito all’epopea ottocentesca del piccolo Marco
di deamicisiana memoria, “Dall’Atlante agli Appennini” è un tuffo
spregiudicato e disinibito nella contemporaneità. Il penultimo racconto
mensile del “Cuore” racconta l’odissea di Marco, “un ragazzo genovese di
tredici anni, figliuolo d’un operaio” che parte da solo per l’Argentina
alla ricerca della madre, domestica presso una ricca famiglia del posto,
di cui non si hanno notizie da molti mesi. Maria Attanasio, che,
magistralmente, ha sempre coniugato l’invenzione narrativa alla ricerca
storica (“Correva l’anno 1698 e nella città avvenne un fatto memorabile”
1994; “Di Concetta e le sue donne”, 1999; “Il falsario di Caltagirone”,
2007), va dritta al cuore del dramma dei clandestini - partiti mille volte
per sfuggire alla miseria e alla malasorte della loro anima peregrina –
attualizzando la problematica della ricerca disperata e dell’esodo forzato
mettendo al posto del ragazzino ligure un suo coetaneo marocchino nell’era
“apocalittica della globalizzazione”, della tragica erranza degli ultimi
verso mete che molto spesso si rivelano pure illusioni.
Così, spiega l’Autrice, “Marco è
diventato Youssef, il suo paese non è ai piedi dell’Appennino ma
dell’Atlante marocchino, l’Eldorado non si chiama Argentina ma Italia”.
Youssef, dopo un fallito tentativo di raggiungere l’Italia dalla Spagna,
si imbarca in Libia su una sorta di traghetto della vita e della morte,
che è insieme arca di Noè e vascello di Caronte. La partenza si rivela
subito una tragedia per alcuni che restano travolti dalla massa
incontrollabile dei clandestini in cerca di un posto. Giunto in Sicilia,
quasi come un naufrago privo di identità, Youssef perde il suo nome
diventando Giuseppe, “nome che risolutamente rifiuta, rivendicando per sé
quello di Marco, come il protagonista di una fiction italiana per ragazzi
che aveva visto alla televisione”. Nel suo lungo peregrinare per la
Penisola, nel desiderio irrefrenabile di ricongiungere il proprio cuore a
quello della propria madre Youssef incontra tanti suoi “paesani”. Pagine
disperate il cui grido di accoglienza, di giustizia sociale, bussa al
cuore del lettore che è condotto in full immersion nella narrazione per la
quale l’Autrice sente l’esigenza dirompente di raccontare non “una”
storia, ma “la” storia proposta, scrive Maria Attanasio, “per conforto di
speranza; di giustizia realizzata. Che non c’è, ma ci può essere. Perché
nel racconto anche la vita che non è, prende la parola e si fa vita”.
E di ciò si è fatta interprete l’Autrice con il suo “cunto” inframmezzato
di immagini, sorta di flash gravidi di laceranti pensieri disegnati, che
scandiscono il testo e che fanno breccia nell’animo del lettore attraverso
la tecnica a carboncino del disegnatore Francesco Chiacchio.
Giuseppe Nativo
Ragusa, novembre 2008